Agostino De Rosa: ricerche in corso
through a glass darkly: vita e
opere del padre minimo Jean-François Nicéron

Michel
Lasne, Ritratto di J.F. Nicèron, Roma (1640-1642)
Jean-François
Nicéron, tra prospettiva e magia
La ricerca (suddivisa in tre fasi) intende affrontare lo studio
critico-filologico dell’opera prospettica del padre minimo Jean-François
Nicéron (1613-1646), e segnatamente del suo celebre trattato intitolato Thaumaturgus opticus (Parigi 1646). L’unità di ricerca,
composta da alcuni studiosi di Storia
dei Metodi di Rappresentazione
(Agostino De Rosa, Giuseppe D’Acunto, Cristian Boscaro), si avvale del
prezioso contributo della filologa classica dott.ssa Ilaria Rizzini, che ha
curato la traduzione dal latino del testo in esame. Scopo della ricerca è
quello di mostrare la complessa struttura retorico-scientifica del trattato,
sia rispetto alla coeva produzione di settore, sia anche alla sua precedente
edizione francese (La perpsective
curieuse, Parigi1638), anche questa, appositamente tradotta (a cura della
dott.ssa Gava).
Oltre all’edizione critica del trattato, il team di ricerca ha
affrontato anche lo studio della
restante produzione artistica del minimo francese, segnatamente
occupandosi delle anamorfosi gemelle di Emmanuel Maignan e di Jean-François
Nicéron stesso presso il Convento di Trinità dei Monti, Roma.
Di questa fase della ricerca, parzialmente conclusa, diamo di seguito
alcuni sintetici cenni.
fase 1
l’apocalisse
dell’Ottica: le anamorfosi gemelle di Emmanuel Maignan e di Jean François
Nicéron a Trinità dei Monti, Roma
Oltre al refettorio realizzato da padre Andrea Pozzo
s.j. (1694) e alla ‘camera picta’ di Ch.L. Clèrisseau (1767), il
Convento di Trinità dei Monti a Roma conserva due importanti testimonianze
della tradizione prospettica Seicentesca, elaborate all’interno del
silenzio claustrale: la celeberrima anamorfosi palindroma di San Francesco di
Paola in preghiera (1642), ideata da da padre Emmanuel Maignan e un altro
importante affresco accelerato prospetticamente, ritraente San Giovanni evangelista
nell’isola di Patmo, dipinto a colori sulla parete del simmetrico
corridoio orientale, la cui struttura geometrico-configurativa è riconducibile
al padre minimo Jean-François Nicéron. Collegato al primo dalla galleria
trasversale sulle cui pareti interne è proiettato un astrolabio progettato
dallo stesso Maignan – forse in collaborazione con Nicéron –,
questo corridoio è stato oggetto, nel corso dei secoli, di numerosi e massicci
interventi di trasformazione, soprattutto durante l’occupazione settecentesca
del convento da parte delle truppe francesi, al punto che il prezioso affresco
anamorfico si credeva oramai perduto sotto pesanti strati d’intonaco e
pittura, finché recenti sondaggi non ne hanno riportato alla luce alcuni frammenti.
La disposizione di questi tre apparati decorativi – le due anamorfosi
‘gemelle’ e l’astrolabio – ad uno stesso piano
dell’edificio lascia intendere, in virtù del tema che sviluppano
(l’ottica e le proiezioni prospettiche nelle sue più ampie applicazioni,
compresa la gnomonica) e dei rapporti tra i relativi autori, una strategia
distributiva e fruitiva che doveva presumibilmente assecondare una
sequenza logico-dimostrativa, o
rituale-meditativa: oscillante tra i due poli devozionali dell’Ordine dei
Minimi, il pio fruitore attraversava uno spazio temporalizzato dalle proiezioni
gnomoniche, capaci di indicare
l’ora e fornire altre informazioni astronomiche per ciascun punto del
globo terrestre toccato dall’apostolato dei Minimi. Il verso di
percorrenza di questi spazi posti in rapida successione doveva certo rivestire
un significato preciso nello svolgimento peripatetico del messaggio criptato
negli apparati decorativi, e che si sta tentando di decifrare, insieme alla
consistenza dell’affresco ‘assente’ del Nicéron, conducendo,
grazie alla costruzione di un modello digitale dell’intero complesso,
alcune analisi ‘proiettive’ proprio sul San Francesco di Paola in
preghiera del Maignan.
Queste opere sono profondamente radicate nella storia del complesso conventuale,
la cui storia è brevemente ripercorsa nel presente saggio, e costituiscono un
suggestivo e inquietante riflesso figurativo della temperie
culturale-scientifica che caratterizzò la Roma del XVII secolo, e segnatamente
i circoli speculativi gravitanti intorno agli ordini religiosi dei Minimi e
dei Gesuiti. Vengono qui ripercorsi
criticamente i curricula vitae et
studiorum dei padri Maignan e Niceron, figure chiave anche per
l’evoluzione della teoria prospettica coeva, grazie soprattutto alla
pubblicazione di alcuni loro trattati, eredi delle tradizioni rappresentative
del passato, ma anche influenti nell’inaugurare un nuovo approccio alla
questione del vedere e del raffigurare. Il tema di ricerca che accomunò i due
scienziati fu quello delle anamorfosi – dirette e catottriche –, e
gli affreschi adornanti i corridoi del I piano del complesso pinciano furono
eseguiti in un disteso ma, comunque, presumibile clima competitivo, tenendo
conto anche del fatto che il Nicéron
(allora ventinovenne) era stato, in precedenza, collega del Maignan (allora
quarantunenne) presso il collegio di Trinità dei Monti durante il suo primo
soggiorno romano del 1639.
Attraverso il ricorso a procedure di fotomodellazione, solitamente
impiegate in tradizionali contesti di rilievo indiretto, è stato possibile
controllare se la posizione di vantaggio acquisita spontaneamente
dall’odierno – come dall’antico – fruitore
dell’anamorfosi superstite (quella ritraente San Francesco di Paola in preghiera) coincidesse con quella prevista
scrupolosamente nel trattato da padre Maignan. Quello dell’image-based modelling è un campo di
ricerca molto frequentato negli ultimi anni e che permette un ampio spettro di
applicazioni nell’ambito della rappresentazione digitale, vista la sua
intrinseca disponibilità ad essere impiegato in indagini anche in modo non
convenzionale. Nel caso specifico, infatti, accanto alle tradizionali foto
dell’affresco scattate oggi nella galleria reale, e necessarie per avviare le procedure di
‘calibrazione’ richieste dai software,
viene interpretata, quale ulteriore ‘immagine’ da calibrare con le
altre, un incisione seicentesca di Charles Audran: in tal modo, intersecando
dati iconici di diversa provenienza, è stato possibile individuare da quale
posizione ideale, nello spazio fisico, si dovesse (e ancor’oggi si debba)
collocare il fruitore per percepire le linee anamorfiche delineate dal Maignan
come perfettamente sovrapponibili al ritratto rettificato dell’Audran. Le
coordinate di questo ‘osservatore’ sono sorprendentemente
coincidenti con quelle ricavate dalla restituzione delle tavole provenienti
dalla Perspectiva horaria, il che
confermerebbe il rigore delle costruzioni eseguite dal Maignan prima in vitro, sulle pagine del trattato, e poi in corpore vivi nello spazio fisico della galleria pinciana.
Si può allora avanzare l’ipotesi che la posizione del fruitore
ideale del San Giovanni Evangelista,
nella galleria orientale, sia simmetrica rispetto a quella assunta
dall’osservatore del San Francesco
di Paola ritratto in quella occidentale, potendosi individuare, per
analogia, il luogo nel quale sarebbe stata collocata la ‘macchina
proiettiva’ di Nicéron, al fine di ottenere una prima traccia, sulla
superficie muraria, a cui ancorare i frammenti di affresco riportati in
superficie durante i recenti restauri. Il comportamento divergente di alcune
‘linee’, riemerse in questi frantumi, lascerebbero intuire
l’orditura sintattica dell’affresco, leggibile percorrendo il
corridoio da sud verso nord: proprio al rinvenimento della struttura geometrico-proiettiva
del San Giovanni Evangelista è
dedicata la ricerca in corso presso l’Università IUAV di Venezia in
collaborazioni con le istituzioni – civili e religiose –
italo-francesi che curano la conservazione dei tesori pinciani, e i cui esiti,
ancora in fieri, sono qui esposti.


E. Maignan, San Francesco di Paola in preghiera, Roma 1642.
Convento della SS.Trinità dei Monti, Roma (foto C. Boscaro).
N.B. La fase 1 si concluderà nel 2007, con l’analisi
simbolico-prospettica dell’affresco niceroniano sepolto sotto numerosi
strati di intonaco, e attualmente interessato da complesse operazioni di
restauro.

Saggi esplorativi sull’intonaco del corridoio ospitante l’affresco di J.F. Nicèron ritraente il
San Giovanni scrive l’Apocalisse nell’isola di Pathmos (Roma
1642). Convento della SS.Trinità dei Monti, Roma (foto A. De Rosa).
fase 2 (2007)
pubblicazione dell’edizione critica (con testo a fronte)
del Thaumaturgus opticus, con saggi di A. De Rosa, G. D’Acunto,
I. Rizzini.
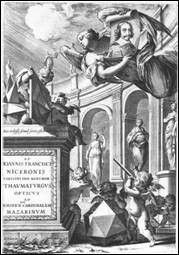
J.F. Nicéron, Thaumaturgus opticus, Parigi
1646. Frontespizio.
fase 3 (2008)
organizzazione della mostra su Jean-François Nicéron presso la chiesa
di San Francesco di Paola
Napoli
coordinatore della ricerca
prof. Agostino De Rosa (Università IUAV di Venezia)
collaboratori alla ricerca
prof. Giuseppe D’Acunto (Università IUAV di Venezia; Politecnico
di Milano)
archh. Cristian Boscaro, Isabella Friso, Gabriella Liva, Cosimo
Monteleone (Università IUAV di Venezia)
dott.ssa Ilaria Rizzini
anno di inizio della ricerca
2004
periodo previsto di conclusione della ricerca
2008
Gli esiti della ricerca saranno pubblicati nel volume:
A. De Rosa, a cura di, Jean-François Nicéron,
tra prospettiva e magia, Firenze 2007-2008 (in
preparazione).
Alcuni estratti della ricerca in corso sono
apparsi nei seguenti saggi e articoli:
- A. De Rosa, Through a glass darkly: vita e opere del padre minimo
Jean-François Nicéron, in “Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei
Minimi”, n° 5, anno LI, gennaio-marzo 2005.
- A. De Rosa, L’apocalisse dell’ottica. Le anamorfosi
gemelle di Emmanuel Maignan e di Jean-François Nicéron, in
“Ikhnos”, Siracusa 2006.
- G. D’Acunto, Il
Thaumaturgus opticus di Jean-François Nicéron: tra rigore geometricoe magia
naturale, in “Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi”,
n° 2, anno LII, aprile-giugno 2006.
- I. Rizzini, Il Thaumaturgus
opticus di Jean-François Nicéron: appunti in margine alla traduzione dal Latino,
in “Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi”, n° 4, anno
LI, ottobre-dicembre 2004.
- I. Rizzini, Il Thaumaturgus
opticus di Jean-François Nicéron: appunti in margine alla traduzione dal Latino,
in “Ikhnos”, Siracusa 2006.
- deformazioni parallele: le due gallerie anamorfiche di Trinità dei Monti
- la Perspective curieuse (edizione consultabile presso la Bibliothèque nationale de France)
- la Perspective curieuse (edizione consultabile presso Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes)
- Marcello Toma su Nicèron
